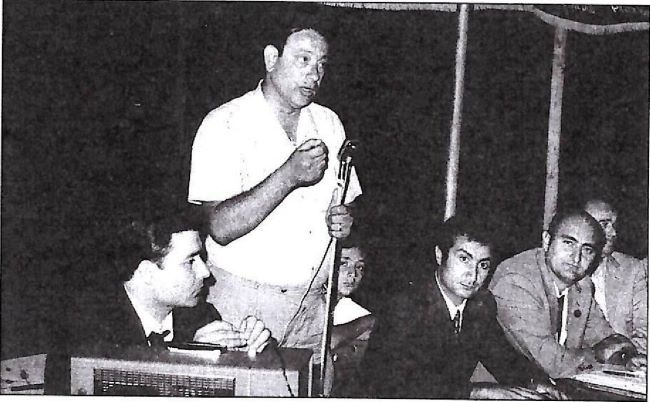
Massoni e Carbonari a Corigliano
La massoneria trae origini dalle corporazioni dei maestri muratori dei secc. XI - XIII, il cui obiettivo è la fratellanza fra gli uomini da conseguire su basi umanitarie e laiche.
I dissidi interni fanno decadere le corporazioni, tanto che, per risollevarne le sorti, si rende necessario annoverare fra le sue fila uomini di prestigio scelti fra gli aristocratici, gli intellettuali, i politici. Con la costituzione della Grande Loggia d’Inghilterra nel 1717 nasce la Massoneria moderna. Essa si sviluppa con l'espansione della potenza anglo-sassone. In Italia sorge per l'azione degli Stuart dimoranti in Roma. Nel 1733 nasce la loggia di Firenze, nel 1736 quella di Bologna. Nel Regno di Napoli già nel 1743 è diffusa per la presenza di una loggia a Napoli e di non poche altre nelle province. Con alterna fortuna si espande e si trasforma. Influenzata dalle idee della rivoluzione francese, si trasforma in movimento politico basato sul trinomio fratellanza-uguaglianza-libertà da raggiungersi anche con la rivoluzione. Nasce, così, la massoneria - giacobina, cui aderiscono i maggiori liberali napoletani dell'epoca, che si organizzano in Clubs propagandistici e di azione miranti ad abbattere la dinastia borbonica ed instaurare la repubblica con l'appoggio della Francia. La massoneria classica, nel napoletano avrebbe potuto dare sbocchi positivi alla evoluzione delle istituzioni se non si fossero verificati gli eccessi del giacobinismo del 1793 e la successiva reazione della Corte. Nel 1793 il coriglianese Antonio Toscano, intrepido eroe di Vigliena, su mandato di Antonio Belpusci, al cui club napoletano è iscritto, fonda a Corigliano la loggia massonico-giacobina intitolata “Sa1a di Zaleuco”. Essa ha sede nel rione Cittadella esattamente ove oggi è collocata la sezione del PCI, sulla cui porta di accesso può ancora notarsi il calco del simbolo rappresentante un maestoso albero di olivo. Anima della fondazione della loggia è certamente Luigi Rossi da Montepaone, poeta e martire della repubblica napoletana, allora dimorante in Corigliano per esserne governatore. Vi aderiscono, oltre i due detti, Orazio Malavolta, Alessandro Grisafi, Antonio De Luca, Fedele de Novel1is. Non si conoscono altri nominativi di aderenti. Comunque, se ce ne sono stati, il numero è molto limitato e certamente non superiore, ad undici complessivamente per come impone l'organizzazione di quei clubs di propaganda. La loggia coriglianese non deve aver svolto nella Città un ruolo politico importante se si considerano gli effetti nei periodi storici più significativi. Essa sorge in un ambiente carico di ideali monarchici e di sentimenti di fedeltà alla dinastia borbonica. Nel 1799 i moti verificatisi in Città sono opera del partito antiducale, il quale non è animato da sentimenti di rinnovamento, né tanto meno da ideali repubblicani, ma solo da proponimenti alternativi nella conquista del potere municipale. Il 1806 non registra posizioni giacobine se non l'isolata collocazione di Alessandro Grisafi, Orazio Malavolta e Marco Oranges nell'esercito francese. Dei fondatori della loggia coriglianese, Luigi Rossi e Fedele de Novellis vengono implicati nella congiura del 1793 e processati. D. Fedele de Novellis, massone dei più convinti, attraverso i suoi molti viaggi lungo l'Europa, si convince della necessità della rivoluzione per cui approda al giacobinismo più estremistico e più ideale. Lo ritroviamo, comunque, decurione anziano e sindaco f.f. nel 1822. Segno questo dei suoi ormai spenti entusiasmi rivoluzionari? Del resto, è certo che molti giacobini, durante il periodo murattiano, delusi dalla politica francese di due re assolutisti, fatta anche di dispotismo, soprusi, prepotenze, persecuzioni che lasciano il popolo sempre in uno stato di oppressione, pensano alla possibilità di instaurare una monarchia costituzionale, magari sotto la dinastia borbonica. Essi, aiutati, in questo disegno, dall'attiva propaganda di lord Bentinche della Corte Borbonica, promuovono la nascita e l'espansione della Carboneria borbonica. La loggia massonica coriglianese si trasforma in Vendita Carbonara intorno al 1814 con titolo «Scuola Sibaritica di Zaleuco». Ha certamente basi borboniche, numerosi proseliti e favori nella opinione pubblica per come dimostrano le grandi manifestazioni di giubilo e ringraziamento seguite alla concessione della costituzione del 1820. Pur ritenendo vasta l'affiliazione alla carboneria, non si conoscono nominativi di nuovi iniziati se non quello di D. Luca Garetti, che al 1820 è il Gran Maestro della Vendita. La Vendita agisce in Corigliano, evolvendo idee e finalità, fino alla unificazione d'Italia. Dalla fine del sec. XIX ai nostri giorni, isolati concittadini aderiscono a logge forestiere della risorta e mutata massoneria. È gente, per lo più del ceto dei professionisti, che s'aggancia all'organizzazione spesso per ottenere privilegi e riconoscimento di valore che non ha. La degenerazione della P2 fa riflettere anche sulle organizzazioni socialpolitiche moderne, spesso ricovero di uomini che annichiliscono gli ideali popolari e fugano le masse da quei movimenti che determinano il progredire dei popoli.




