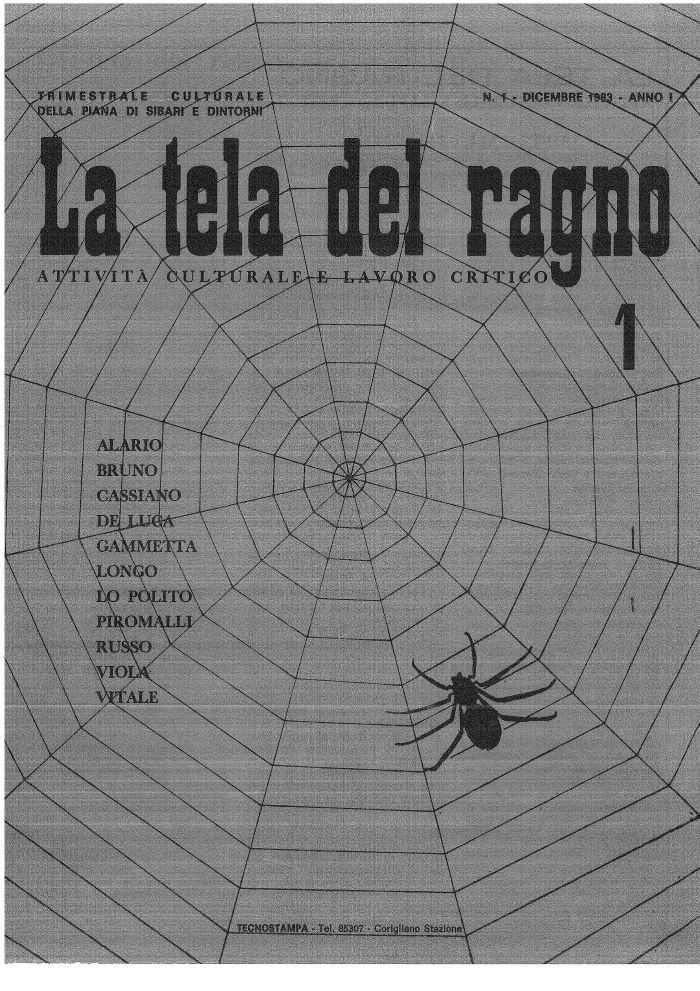
Esigenza di approfondimento teorico e di rigore scientifico nella situazione attuale e recente della critica letteraria marxista in Italia - di Armando Gammetta- Terza ed ultima parte
Tratto dalla rivista "La Tela del ragno" n. 1 del 1° dicembre 1983
Quando Cassirer, in una famosa conferenza tenuta nel 1945 poco prima di morire, salutava - alludendo ad un famoso passo del Sofista di Platone -l'avvento della linguistica strutturale come una vittoria degli «amici delle idee» sui «fautori della materia», era troppo buon conoscitore e di filosofia e di linguistica moderna per sbagliarsi.
Ciò dimostra quanto sono superficiali e frettolose certe «unificazioni ideologiche» tra marxismo e linguistica strutturale che, a quanto risulta, si stanno compiendo in Unione Sovietica» (16). È veramente grande la capacità e il rigore critico - materialistico di S. Timpanaro, che ci ha insegnato una seria lettura dell'Ottocento e, soprattutto, del Leopardi, spesso in dissenso con tanti critici pure marxisti.
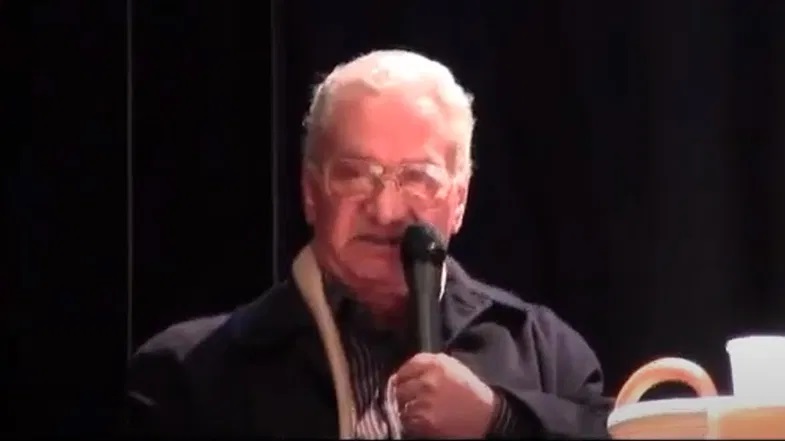
Ma, a questo punto, in cosa consiste la carenza di approfondimento teorico e di rigore scientifico nella critica letteraria marxista o almeno in una parte di essa, dato che dallo scontro lo strutturalismo visto è uscito con 1e ossa rotte? Consiste in due cose, a mio avviso: 1) atteggiamento di chiusura e rifiuto totale dell'analisi strutturale, 2) acritica commistione con essa. Il rifiuto totale risulta errato o perlomeno due fatti: 1) il non tenere conto degli sviluppi e degli approfondimenti dello strutturalismo e formalismo, specialmente linguistici; 2) il non capire, che, pur rimanendo profondamente diversi, marxismo e strutturalismo hanno una comune esigenza di rigore scientifico - metodologico che sfocia nel presupposto comune della funzione conoscitiva e non valutativa dell'analisi critica.

Ad un giudizio di valore, semmai, si arriverà dopo questo momento conoscitivo. Procediamo con ordine: non parliamo della acritica commistione, perché in quanto tale non ha niente a che fare con l'approfondimento teorico e con il rigore scientifico marxisti: essa è solo una ibrida giustapposizione pseudo - interdisciplinare (con assenza totale di procedimento dialettico) di metodologie di diversa natura; trappola per molti sedicenti critici marxisti. Parliamo, invece dei due fatti che dimostrano l'erroneità del rifiuto totale dell'analisi formale-strutturale. Per il secondo, mi sembra che abbia ragione Rosiello: «Prescindendo quindi dalla contingenza della polemica, si può tranquillamente affermare che- sia la critica linguistica d'ispirazione strutturale, sia la critica sociologica d'ispirazione marxista operano entrambe sulla base di un fondamento metodologico comune che assegna all'analisi dei testi letterari una finalità conoscitiva (e non valutativa) e una funzione esplicativa». Va detto, però, che lo stesso Rosiello spesso cade nel giudizio valutativo, in contraddizione con la sua ricerca assolutamente avalutativa : il suo saggio montaliano praticamente ha per conclusione che lo scrittore che sviluppa di più la funzione della lingua è «maggiore» scrittore. Rosiello è bravissimo, il fatto è che la contraddizione è implicita nel metodo!
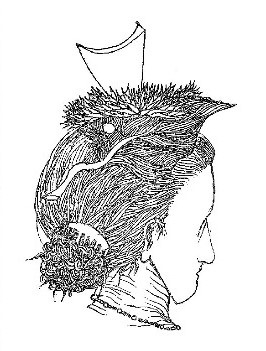
Questa contraddizione del Rosiello è rilevata da Romano Luperini (18). Quanto al primo fatto, che dimostra l'erroneità di quel rifiuto, mi sembra che la critica letteraria marxista, proprio per esigenza di approfondimento teorico e rigore scientifico, debba tener conto di certi sviluppi e approfondimenti: 1) lo slittamento astorico del metodo formale russo non è caratteristica dell'origine del formalismo, si spiega più con la «pressione di un clima apertamente antimaterialistico: le stesse dottrine delle scuole di Copenaghen e di Praga, pur presentando importanti acquisizioni scientifiche, si rivelano ben altrimenti « ideologizzate» rispetto alla dottrina saussuriana» (19) che pure aveva delle controtendenze realistiche. Nel proemio di Broundal agli Acta linguistica (1939) il platonismo è tutto presente, intento a scoprire strutture immobili della realtà. In origine, invece, i formalisti russi dell'Opojaz ( 1916) (Società per lo studio del linguaggio poetico) non avevano nessuna teoria , nessuna metodologia; è lo stesso Boris M . Ejchenbaum (uno dei maggiori rappresentanti, insieme a Sklovskij, Tynyanov, Jakobson, ecc., del formalismo russo) a dirci che inizialmente lo scopo era solo quello di «combattere la poetica dei simbolisti ... e svincolarla dalle loro teorie estetiche e filosofiche soggettive, rimetterla sulla via dell'indagine scientifica dei fatti» (20), e ciò viene formulato con precisione da Jakobson: «oggetto della scienza della letteratura non è la letteratura, ma la letterarietà , cioè ciò che di una data opera fa un'opera letteraria» (21). Sull'origine del formalismo russo la critica letteraria marxista italiana dovrebbe riflettere. Continuiamo con altri sviluppi e approfondimenti da tenere presenti: 2) La mediazione sintetica tra ipotesi strutturaliste e metodo dialettico marxista, operata da Mukarovschj, dopo lo sviluppo funzionalista del metodo formale da parte della scuola praghese; 3) la scoperta delle varie funzioni della lingua; 4) i concetti di norma e scarto, la nozione di fonema, l'importanza delle descrizioni sincroniche quando illustrano stati linguistici; 5) l’antiformalismo di un Martinet e la sua esigenza di realismo, pur essendo un linguista strutturale; 6) la diversità dello strutturalismo americano da quello europeo; 7) il recupero dell'istanza diacronica, quando il metodo formalistico e strutturalistico si incontra con i critici della storia della lingua, come, per esempio in Italia, il gruppo della scuola di Pavia. D’altronde, lo stesso Segre pubblicò nel 1977 un libro molto significativo nel titolo: Semiologia, storia e cultura. Ma, soprattutto, la critica letteraria marxista italiana deve riconsiderare il grande contributo di Galvano della Volpe, rimasto per molto tempo isolato nell'area critica e politica dello stesso marxismo ! Eppure, con la sua Critica del gusto (1960), in cui confluiscono e si raffinano contributi presenti in altre sue opere, della Volpe rappresenta il punto più alto dalla ricerca marxista in estetica, teoria e metodologia critica, ricerca che Ignazio Ambrogio ha approfondito nel suo studio Ideologie e tecniche letterarie (1971) attraverso il criterio di sistema - funzione della letteratura, oggi l'analisi storico-filologica delle connotazioni del testo in rapporto con le denotazioni dell'uso linguistico comune.
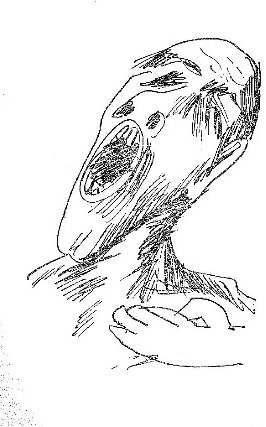
Il contributo di Galvano della Volpe si caratterizza per alcuni punti fermi. Discorso poetico, discorso scientifico e altri discorsi hanno in comune il fatto di essere discorsi, cioè procedimenti razionale - intellettuali. Dunque, cadono i concetti di «sensibilità », « sentimento », « fantasia », «immaginazione», e la crociana intuizione lirica come produttori dell'operazione artistica, perché il discorso poetico è, appunto, procedimento logico-intellettuale, anche se particolare. Anche, e soprattutto, le fantasie, ariostesche per es., sono in preciso rapporto col dato vero e reale, anche se in antitesi, e senza quel dato sarebbero un non-senso. La stessa metafora non è una esclusività del linguaggio poetico. Ma, allora la differenza tra discorso (linguaggio) poetico e altri discorsi sta solo nel fatto che il primo è organizzato e funziona diversamente dagli altri, cioè esso è connotativo e polisenso, ossia la sua peculiarità è , l'organicità contestuale connotativa; mentre gli altri discorsi , gli altri linguaggi sono solo denotativi. Polisenso, in relazione ai valori espressivi, significa che questi sono costituiti da un di più di senso rispetto a quello dei valori relativi agli altri linguaggi, non poetici. Allora, l’organizzazione del testo poetico ha co me sua peculiarità l'organicità semantica: dunque, tutta l'attenzione si sposta sull'aspetto semantico: e quindi lo specifico letterario coincide con il carattere semantico. E così Galvano della Volpe può utilizzare la linguistica strutturale di Saussure e di Hjelmslev in funzione di un esito materialistico storico del problema dell'opera letteraria. Carattere semantico vuol dire che l’analisi di un testo letterario deve essere scientifica, attraverso il continuo rapporto tra langue (istituzione collettiva) e parole (creazione individuale), e la conoscenza di questo rapporto è ovviamente di carattere storico, e nel testo, dunque, fatto di parole, espressioni organizzate, c'è la storia con tutto ciò di cui è costituita, e questa è allora interna al testo. Che vuol dire? Vuol dire che Galvano della Volpe ha sovvertito radicalmente la teoria crociana dell'arte, vuol dire che l'autonomia della poesia è autonomia semantica, scientificamente conoscibile, e non metafisica: autonomia nella storia e non dalla storia. Dunque, anche l 'ideologia e la storicità sono interne.. infratestuali, nella opera. Allora, il testo poetico , l'opera artistica, che contiene il discorso comune - denotativo, attraverso questo linguaggio comune risulta connesso con tutte le condizioni storiche dalle quali e nelle quali è nato. Che vuol dire? Vuol dire che Galvano della Volpe supera e risolve le difficoltà in cui si arenava la pur importantissima critica marxista lukacssiana, goldmannina, e le difficoltà in cui si arenava la critica formalistico strutturale, mentre recupera l'interesse per Gramsci e per la semiologia , sfrondata però d'ogni tendenza formalistico-strutturale. Viene risolta anche, per es. la difficoltà che Antonio Banfi (Arte e socialità, 1956) aveva nel saldare la storicità delle tecniche con la storicità integrale dell'opera letteraria. Molto ancora si dovrebbe dire di Galvano della Volpe, ma fermiamoci qui. Ma, come nel 1960 la Critica del gusto di Galvano della Volpe aveva significato una rottura nella critica letteraria marxista, così nel 1965 il libro Scrittori e popolo di Alberto Asor Rosa segnò un momento decisivo e di svolta di quella critica. I1 libro di Asor Rosa, insieme con l 'altro, Verifica dei poteri, pure del '65, di Franco Fortini, fu l'inizio, sì sa, di quella importantissima attività critica neomarxista che, grazie agli studi di Madrignani, Luperini, Imenghi , Ceserani, ecc. (e non parliamo dei grandi contributi venuti dagli studi di Antonio La Penna, filologo classico che ci ha illuminato sulla letteratura latina augustea, e di Sebastiano Timpanaro, grazie al quale abbiamo capito tante cose sull'Ottocento e Leopardi), rompendo con lo storicismo marxista e negando la cultura borghese , praticava una critica addirittura alla letteratura in perfetta coerenza con l'assunzione del punto di vista operaistico e rivoluzionario derivante dai «Quaderni russi». La nuova critica marxista produsse notevoli contributi sulla valutazione del neorealismo, del marxismo postbellico ormai superato, di Verga, della politica culturale del PCI ; ma, soprattutto, Asor Rosa col suo Scrittori e popolo decisamente criticava il carattere populista di tanta parte della letteratura dell’Ottocento e Novecento, e criticava anche Gramsci per non essere stato rivoluzionariamente drastico verso quella letteratura. Dunque, sembrava che la posizione asorrosiana imboccasse la via coerentemente materialistica della ricerca critica marxista. Ma non fu così: la sua storia del populismo non è fondata sull'analisi del rapporto dialettico con il contesto storico-economico-sociale e trasformazioni strutturali derivanti, è, al contrario, una «storia dell'idea populistica», come dice Luperini (22). Non solo, ma, essendo il confronto tra «letteratura piccolo - borghese, populista, e letteratura grande borghese, decadente, il criterio di valore... si appoggia a categorie idealistiche » (23) . Ciò significa che Asor Rosa si allontana dal rigore teoretico critico marxista e si avvicina ad una valutazione delle cose secondo il «corso storico come di fatto si è sviluppato», dice Luperini, finendo col non capire l'importanza rivoluzionaria di opere e uomini schiacciati dal corso storico. Mi viene in mente quel momento, quando Muscetta precisava che la responsabilità del volume sul '600, de La letteratura italiana. Storia e testi (1972-'80), ricadeva su Asor Rosa: era chiara la discordanza tra i due studiosi. Su questi passaggi asorrosiani è molto critico Luperini, che li definisce una sorta di giolittismo, di compromesso. Forse non aveva torto Muscetta, il critico marxista che ha saputo cogliere anche i livelli psicologico e formale dell'opera letteraria, e che ha saputo utilizzare la lezione di Bachtin, marxista critico russo che, senza cambiare la base materialistico-dialettica, ha fatto bene, come si suol dire, i conti con Freud, Croce, Saussure, linguistica strutturale, formalismo russo. Allora, a cosa sono dovuti certi tentennamenti asorrosiani e certe sue involuzioni? Anche qui il difetto è una carenza di approfondimento teorico e di rigore scientifico, se vediamo le cose dal punto di vista della teoria critica marxista, e Asor Rosa, in quanto marxista, non poteva avere un punto di vista diverso. Giolittismo, compromesso più o meno storico, in capacità teorica di uscire dal momento contingente? Forse. Certo, quella carenza teorico-scientifica rimane! Dopo il '68, con le varie delusioni, frustrazioni ed i vari riflussi, la situazione letteraria italiana è così caratterizzata da Giuseppe Petronio: «Di impegno ideologico, adattamento conformistico ai disegni dell'industria e del mercato librario, banalizzazione dei mezzi espressivi già «alti» convergono nella nascita di un'attività letteraria nella quale tutte le distinzioni tradizionali sono scomparse e tutte le commistioni sono possibili, fino alle più ibride» (24). Ciò significa che il concetto di letteratura si è dilatato: ogni cosa scritta è testo, scrittura, letteratura; allora, l'opera letteraria cade dalla sua altezza tradizionalmente elitaria, viene sconsacrata, perde l' aura e laureola, diventa di massa, come di massa è la società, anche se certamente diversificata e stratificata. I generi letterari cadono: anche se con qualche eccezione, la letteratura un tempo alta, seria e impegnata è costretta ad incontrarsi (e trasformarsi) con la Trivialliteratur (da Trivium: luogo di convergenza dii più strade), una letteratura della comunicazione quotidiana e dello svago, di cui cominciò ad occuparsi il Kreuzer nella cultura tedesca (1965), e pochi anni dopo anche i nostri studiosi, tra cui Giuseppe Petronio, che ha già lucidamente di mostrato come questa nuova attenzione critica democraticizzi la letteratura e gli studi relativi attraverso il recupero di tanta parte di letteratura che prima non era considerata tale. Naturalmente, la critica letteraria degli anni '70 e d'oggi non poteva non trasformarsi anch'essa, dal momento che il suo oggetto di studio si era trasformato. E allora la critica letteraria diventa sempre più semiologica, viene detta semiocritica, fino a dominare sugli altri orientamenti, e questa semiocritica ingloba in sé la critica formalistica e strutturalistica, si confonde con quest'ultima: eppure, la semiologia non è un orientamento relativo alla critica letteraria, essa vuole essere, come avverte Umberto Eco, una scienza che tutto riduce ad un grande sistema di segni, vuole occuparsi di tutta la cultura ridotta a sistema di segni; mentre, per quanto riguarda la critica letteraria, può certamente suggerire a questa nuovi campi di ricerca come è avvenuto, per esempio, per la narratologia). La semiocritica, dunque, ha nel suo interno un equivoco: può essere giusta utilizzazione della semiologia e può essere un'aggiornata nuova «edizione» della critica formalistica e strutturalistica con i difetti e le carenze di questa. Di qui l'uso neoidealistico e ideologicamente neo capitalistico che se ne fa, dominante in questi ultimi anni, e l'atteggiamento doppiamente errato di molta critica marxista nei suoi riguardi. Doppiamente errato: perché tanti critici marxisti, accettando la semiologia, praticano in campo letterario la semiocritica, senza sapere evitare i difetti formalistico-strutturalistici (eppure della Volpe era riuscito ad evitarli!); e perché, volendo essere buoni critici marxisti, «attaccano» frontalmente tutto l'arco semiologico, pensando, così facendo, di sconfiggere la semiologia! Ebbene, anche qui la critica marxista non brilla molto per approfondimento teorico e rigore scientifico. Ancora una vo1ta dobbiamo dire che il problema non è quello di rigettare ciò che non è marxista, bensì quello di vincere il confronto con altri orientamenti e metodologie, e questa vittoria si può ottenere facendo progredire la critica marxista attraverso un serio approfondimento sulla base della propria identità e non attraverso commistioni, giustapposizioni, accostamenti di moda, che producono salo ibridismi, perdita di identità, confusioni e smarrimenti. Io non temo l’errore, temo la confusione. Allora, se la situazione attuale della critica letteraria marxista è situazione di crisi, cosa bisogna fare per uscire da questa crisi? Già nel 1979 Giuseppe Petronio (25) rimproverava alla critica letteraria marxista tre limitazioni: 1) «È stata solo o quasi solo una sociologia dell'autore»; 2) «Difetta spesso a quella critica il riconoscimento della possibile positività sociale della letteratura di consumo... un difetto, in un certo senso, di spiriti democratici»; 3) «Anche questi problemi (i canali di distribuzione che portano l'opera d'arte al pubblico, la fruizione del pubblico, la reazione dei contemporanei dell'autore, lo sviluppo della critica) non sono stati affrontati in modo esauriente e corretto». Petronio, pur sottolineando i grandi contributi apportati da quella «sociologia dell'autore», da quel «difetto di spiriti democratici» (ma questo è problema che merita un particolare approfondimento che non facciamo qui) che insisteva sull'affascinante senso della grande opera, proponeva, per uscire dalla crisi, una analisi letteraria integrale, cioè «di tutti gli elementi che concorrono alla nascita dell'opera: autore, messaggio, contesto, codici; ognuno dei quali va esaminato, analizzato, giudicato nella sua storicità e socialità, cioè nella sua rispondenza a una società e a una età», studiati cioè marxisticamente. Dunque, l'approfondimento e il progresso della critica letteraria marxista non possono avvenire attraverso un colloquio con la cultura moderna nel senso di giustapposizione e ibridismi di principi, metodologie e tecniche di diverse nature, ma devono avvenire attraverso un colloquio con la cultura moderna mantenendo la propria identità. E allora «dirsi marxista significa richiamarsi a un nucleo di principi di carattere materialistico e dialettico, e quindi rifiutare tutte le spiegazioni della vita sociale e dell'arte che non possano essere riportate a principi o presupposti di natura materialistica o dialettica». Nella critica letteraria, dirsi marxista «significa rifiuto dell'idealismo crociano o di qualsiasi altra forma di idealismo... di ogni concezione o corrente (strutturalismo) che teorizzi e pratichi l'analisi dei soli elementi costitutivi del testo e del loro organizzarsi in strutture significative, eliminando tutto ciò che sta intorno al testo (contesto), fino addirittura a cancellare l'autore... di ogni forma di critica che si illuda di includere il testo letterario riportandolo solo a eventi o traumi psicologici della prima o primissima infanzia ... legati ad una immobile natura umana, riducibili a una tipologia, tutto sommato, assai povera, iterantesi nei medesimi modi in tulle le età, in tutti i paesi, in tutte le condizioni sociali». In questo suo progetto, politico anche, perché vuole precisare la funzione che la letteratura ha avuto lungo il corso storico, Petronio, per evitare certi rischi sociologici o addirittura peggiori di questi, ricorda molto opportunamente Galvano della Volpe, il quale diceva che le opere d'arte sono « matrici formali , condizioni sì di sviluppi dialettici e semantici, ma secondo fini determinatissimi '' (Opere, Roma, Editori Riuniti, VI, p. 405). Romano Luperini, due anni fa (26), indicava il bivio cui è giunta la critica letteraria marxista : « O sarà in grado di rinnovarsi decisamente recuperando, in senso materialistico e dialettico, una carica di demistificazione e di critica che d'altronde dovrebbe essere inseparabile dalla sue capacità conoscitiva, oppure dovrà oscillare fra una corsa affannosa all’aggiornamento inseguendo altre discipline, la riduzione a sociologia, la chiusura in forme settarie e panpoliticiste ». Fra le tendenze presenti, prevalente oggi è quella che studia l'universo del destinatario e del codice, e subisce la dominazione della semiocritica: «La morte dell'arte viene non solo accettata, ma promossa e accelerata. È la spinta alla americanizzazione, presente anche nella critica marxista », è l’avvenuta sostituzione del valore d'uso col valore di scambio, che riduce il fatto estetico a merce e l'attività artistica a lavoro alienato ». Allora solo una critica materialistico-dialettica può dare al critico marxista la coscienza di sé, uomo scisso «fra ruolo oggettivo di specialista integrato nelle istituzioni borghesi e nel mondo della produzione capitalistica e la soggettiva volontà rivoluzionaria provocata o agevolata dal processo di proletarizzazione che sta attraversando la massa degli intellettuali ». E così, il testo letterario non deve essere visto come valore assoluto e indagato solo nella sua «coerenza, sublime e sublimante, di forma-unità», né il suo «specifico spessore formale » deve essere affondato «nell'indistinto sociale»; al contrario, l'opera d'arte deve essere concepita «come fascio di conti addizioni, come stratificazioni di significati diversi e di livelli di significato in tensione fra loro, prodotti da un oggetto diviso e destinati a una società scissa dal conflitto di classe (e da altre forme di conflitto)»; è questa concezione che «può trovarle (all'opera d'arte) un posto nel sistema della comunicazione sociale e nel rapporto storico con la realtà e nello stesso tempo percepire in essa il segno e il sintomo di una lacerazione ma anche della resistenza che la vita oppone all’alienazione contemporanea». Romano Luperini accusa, con coerenza correttamente marxista, a mio avviso, la semiocritica di voler mettere in atto «un'operazione di rimozione delle contraddizioni storiche», e già Gianni Scalia aveva accusato, giustamente, secondo me, la semiocritica di voler “rifiutare nei «segni” i sintomi» (in M. Miccinesi, Critica sotto inchiesta, Ravenna, 1976, p. 142). Insomma, i vari approcci delle tendenze metodologiche interne alla logica ed alla mentalità del neocapitalismo borghese cercano sempre di abbattere la funzione conoscitiva dell’arte, «funzione conoscitiva che la classe dominante teme in sommo grado», come diceva Carlo Salinari. Ora, come dovrà avvenire questo approfondimento teorico, questo rigore scientifico, che abbiamo visto troppo spesso debole nella critica letteraria marxista in Italia? Io penso che bisogna studiare meglio (e trarne tutte le conseguenze) le tesi del materialismo dialettico, seguendo le indicazioni fatte nel «Quadro teorico» da Fiorani - Geymonat (Fiorani - Geymonat, Materialismo dialettico e politica, I: quadro teorico, in AA. VV., Critica leninista del presente, Milano 1980). La critica letteraria marxista non deve essere revisionata, magari con innesti vari o giustapposizioni, deve essere invece approfondita rimanendo marxista : approfondimento marxista e non revisionismo. Le categorie marxiste, a cominciare da quelle di Marx, non hanno certamente validità metastorica, ma abbandonarle perché «sbagliate» è certamente un modo di fare non solo non marxista, ma anche non scientifico, sì, perché le nostre conoscenze hanno il carattere oggettivo ma relativo, ed in quanto oggettive, le conoscenze non possono essere mutate arbitrariamente.. ma le eventuali nuove conoscenze, che sostituiscono le prime, devono essere capaci di farci intendere meglio la base oggettiva, la realtà . C'è differenza tra approfondimento marxista (doveroso ed ineludibile) e revisionismo! Nella critica letteraria marxista, per esempio, un esemplare, a mio avviso, approfondimento di rigore scientifico è venuto da Romano Luperini con la nuova periodizzazione del 900 letterario in Italia. Nella storia del marxismo, ogni momento di crisi ha sempre avuto il significato di una esigenza di approfondimento, mai di essere altra cosa : così operarono Lenin e, da noi , Gramsci (questi sono stati capaci di apportare un approfondimento marxista). Nella storia del marxismo la parola crisi non ha necessariamente un significato negativo, significa solo momento storico che esige grande impegno teorico e intelletti all'altezza della situazione, Nella crisi odierna, che è crisi di un marxismo, storicamente determinato, bisogna vedere quale sarà l 'approfondimento che noi sapremo fare, tenendo presenti le tesi del materialismo dialettico; se non ne saremo capaci, allora la crisi è crisi non del marxismo, ma dei marxisti! (27). (FINE)
Le precedenti parti sono state pubblicate: la prima parte il 9.3.2025 e la seconda parte il 23.3.2025




