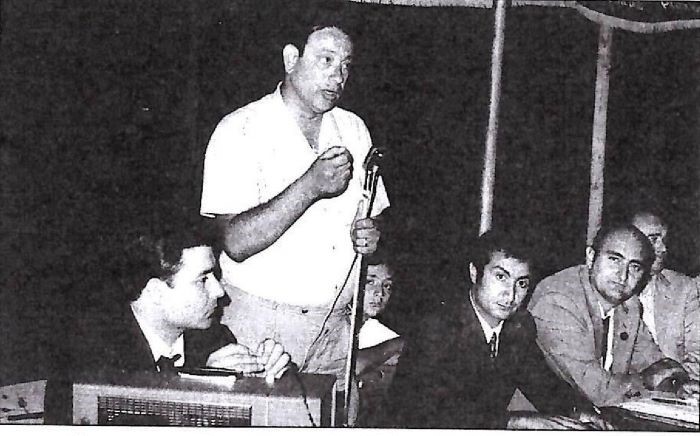
Il Coriglianeto
Una delle determinanti di non lieve importanza, per cui la più parte dei vecchi centri abitati sono posti nelle immediate adiacenze di certi corsi d’acqua è di natura economica. Il Coriglianeto bagna ad ovest il centro storico della nostra città.
Le sue acque, irregimentate, in tutte le epoche sono sfruttate per lo sviluppo socio-economico della zona. La irregimentazione, che non prescinde da una oculata sistemazione del bacino, è fatta da mirabili lavori di arginazione verde di salici, pioppi, ontani, tamerici, ottenuta con «pizzuti» e «fascine”, talee rincalzate con la terra di risulta dall’espurgo dello stesso torrente. Tale tecnica di arginamento dei corsi d'acqua, ereditata dai sibariti, maestri in tema di sistemazione idraulica, è applicata scrupolosamente fino all'abrogazione della feudalità. Per la costruzione ex novo o per la manutenzione annuale di siffatti argini, il feudatario si serve di manodopera specializzata dei casali di Cosenza. Le ultime squadre di «infascinatori», tra la fine del sec. XVIII ed il principio del XIX, vengono ingaggiate, condotte, sorvegliate e dirette dai caporali Vincenzo, Paolo ed Antonio Mancini di Malito. Con l'abrogazione della feudalità subentra il disordine idraulico tant'è che nel settembre del 1810 (contrariamente a quanto riferisce l’Amato) si verifica la più tragica delle esondazioni del Coriglianeto con danni immensi alla campagna circostante. Dalla formazione del feudo di Corigliano, le acque del Coriglianeto sono di esclusiva pertinenza del feudatario fino al 1545. Ciò non toglie che il loro utilizzo è effettuato abusivamente da «particolari» cittadini sia per irrigazione dei «jardini » sia per la fonte di energia. In detto anno, l'Università ed i cittadini interessati, per evitare liti, addivengono ad un accordo con il conte Pietro Antonio Sanseverino per cui, dietro il versamento di 6000 ducati, acquisiscono il diritto di usare le acque sia come forza motrice per i molini che come irrigazione per i «jardini». Di tale accordo possiamo leggere le clausole in un documento notarile dell'epoca. Tra l'Università, la corte feudale ed i cittadini intervenuti nell'atto viene stabilito un turno irriguo settimanale per tredici “jardini» secondo il quale le acque del Coriglianeto restano impegnate per un numero di ore rapportato alla superficie degli agrumeti stessi. Questi appartengono alla corte feudale (Giardino Grande), al convento di S. Francesco di Paola ed alle famiglie Abenante, Perrone, Sollazzo, Mezzotero, Bianco, Falcone, De Rosis, Rugna, Castriota, De Novellis, De Bernardo. Detto turno è confermato nel 1694 per come appare da un atto di fede di quell'anno. Altre proprietà non hanno diritto a derivare acque, ma, evidentemente, data la portata del torrente, si tollera l'uso abusivo per come ci informa anche il Pugliese nell'Istoria Apologetica, ove denunzia la presenza, all'epoca, di venti “jardini” alimentati dal Coriglianeto. L'abrogazione della feudalità e, quindi, la pubblicizzazione delle acque non porta sostanziali modifiche nell'esercizio dell'irrigazione. Il diritto di derivazione, stante sempre la disponibilità idrica, viene via via esteso ai nuovi impianti della vallata del Coriglianeto. Il 26-7-1920 il Ministro dei LL.PP. emana un decreto che regolamenta le utenze irrigue. Da tale atto emerge che la superficie irrigabile per diritto, dai 40 ettari circa del 1545 passa ad 80 ettari, mentre il turno irriguo si allunga ad otto giorni. Oltre che per fini irrigui, le acque del Coriglianeto vengono usate come fonte di energia per l’azionamento dei molini, gualchiere, trappeti, conci. I molini, ai primi del sec. XVIII, sono quattordici (tre della corte ducale); a fine del sec. XIX sono quindici. L’insorgere dei molini elettrici nel sec. XX determina la chiusura dei vecchi molini ad acqua, dei quali, nel Coriglianeto, ne troviamo funzionanti tre fino agli anni 50 ed uno solo fino agli anni 70. Le gualchiere, ovvero le lavanderie di un tempo, sono tre (una della corte feudale). In tali opifici vengono lavati i pannilana con il metodo della «lissia» e con macchinari batti-panni. Essi scompaiono nel secondo decennio del sec. XIX per essere soppiantati dalle lavandaie, le quali, da quell'epoca, assolvono anche al lavaggio dei pannilana per cui si attrezzano di caldaie mobili e di «mazze» (batti-panni) di legno. I trappeti azionati sono tre: Arpa, Pendino, Belladonna. Quello del Pendino, di pertinenza della corte ducale, nel 1715 viene trasformato a molino per il Concio. Quello dell'Arpa funziona fino agli anni 70 di questo secolo. Nel 1891, in occasione della visita del principe Vittorio, il castello viene illuminato per l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, installata nel Coriglianeto, a Petrara, dalla ditta Antonio Cimino. Tale centrale, successivamente, servirà il centro storico per la illuminazione sia pubblica che privata. Le acque del Coriglianeto, nei tempi andati e maggiormente durante il sec. XVIII, vengono utilizzate per la macerazione del lino nelle «vurghe» preparate nella parte bassa del torrente. Infine ricordiamo che il greto del Coriglianeto ha, in tutti i tempi e fino ad un decennio fa, fornito ottimo materiale da costruzione (sabbia, pietrisco e pietrame). Oggi il Coriglianeto viene utilizzato solo a fini irrigui con tipo di derivazione vecchio di secoli. Per la insipienza dei nostri governanti esso costituisce pericolo permanente da esondazione e da inquinamento del mare con tutti i riflessi negativi per l'economia ed il turismo locale.




