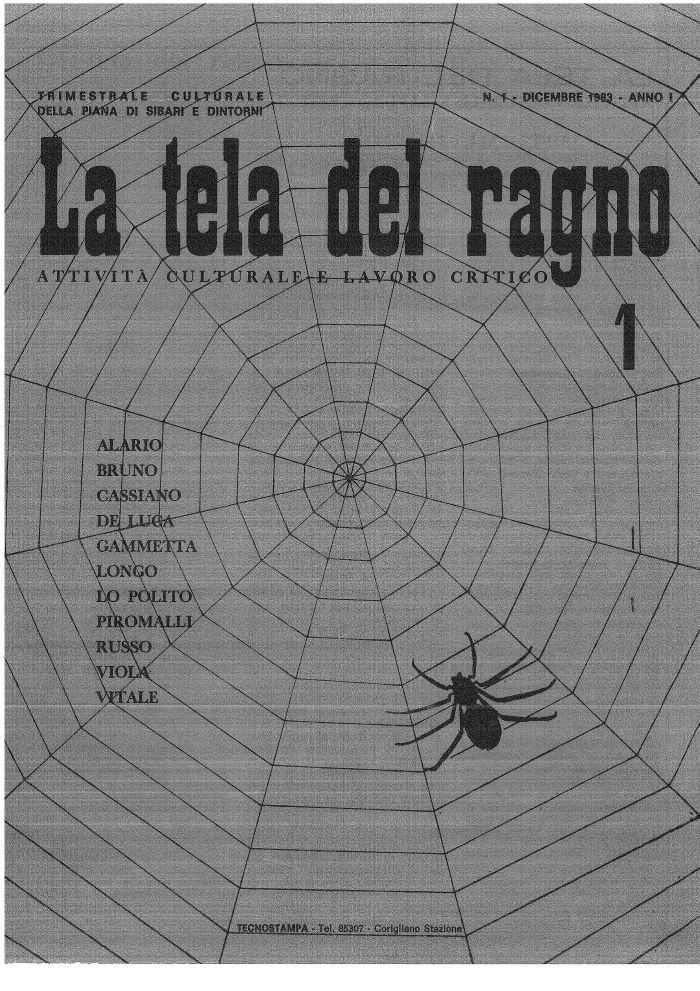
Esigenza di approfondimento teorico e di rigore scientifico nella situazione attuale e recente della critica letteraria marxista in Italia - di Armando Gammetta - Seconda Parte
Tratto dalla rivista "La Tela del ragno" n. 1 del 1° dicembre 1983
Così l’intellettuale marxista non sa criticare il proprio ruolo, la sua posizione di classe: ne consegue anche in letteratura un apporto critico per molti versi utile, ma, sul piano teorico-scientifico, quasi inconsistente.
È significativo che Galvano della Volpe, il più acuto tra i pensatori marxisti italiani per il settore della teoria e metodologia letteraria, resterà per molto tempo un solitario, isolato, nella cultura della Sinistra, anche se era l'unico mentalmente attrezzato a dare il definitivo colpo di grazia all'idealismo crociano, e questo sul piano teorico-scientifico. Cosa accadde nella critica marxista dalla diffusione degli scritti di Gramsci ('47-'48) agli anni '56-'57? Sono come disse Franco Fortini molto significativamente, i Dieci inverni, caratterizzati dal pessimismo nei riguardi della fiducia e speranza resistenziali, dalla guerra fredda fra Russia e America, dallo stalinismo e, specificamente in Italia, dall'atmosfera clerico-fascista del potere dominante.
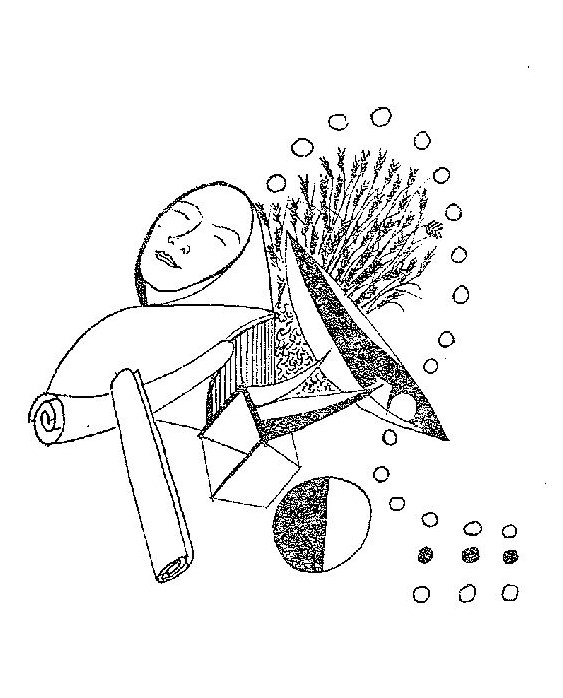
È così fu, in Italia, l'unità d’azione tra PSI e PCI e, nella cultura, lo zdanovismo. La critica marxista ora pecca di chi usura e di provincialismo, respingendo per partito preso e acriticamente ogni novità culturale proveniente dal mondo borghese; l'impegno dello scrittore e del critico coincide con la volontà del partito, la sola poetica valida è quella del «realismo socialista». È il momento in cui Emilio Sereni propone la linea. Lenin Gramsci - Stalin-Zdanov. Ma, nello stesso tempo questo marxismo «ortodosso» si proponeva larghe alleanze con le altre correnti culturali nazionali e con i filoni tradizionali: questo tentativo poteva avere in politica una sua ragione, però in sede teorico-scientifica, con, riferimento ai problemi della metodologia letteraria, era un non-senso. Infatti, Sereni voleva una organizzazione autonoma della cultura con uomini non importa di quale parte ideologica o politica: è evidente che voleva calamitare i ceti medi. Per fini di utilità politica Gramsci veniva piegato ora verso De Sanctis ora verso Zdanov, e lo stesso Lukacs veniva piegato alle esigenze italiane, ora accettato ora « usato ». In conclusione, le due linee in cui era stato inserito Gramsci alla fin fine non proponevano altro che un marxismo identificantesi con l’ideologia; anche qui non c'era approfondimento teorico e rigore scientifico, sì, perché il marxismo è soprattutto la scienza che ha per oggetto di studio il rapporto teoria-prassi non disgiunta dalla lotta di classe.

Proprio per le sue caratteristiche e contraddizioni questo marxismo ortodosso venne superato ···dall’altro, detto critico, il quale portava avanti il dissenso, la critica, l'autogestione della cultura, l'assunzione critica del «nuovo» proveniente dal mondo borghese, così come intendeva (con Fortini) anche il problema critico - sociale del committente e del pubblico, l'importanza della Scuola di Francoforte e delle lezione di Lukas. Ma «l'organizzazione capitalistica della cultura - come dice Luperini dimostrò quanto fosse illusorio il tentativo del marxismo critico che voleva mantenersi puro e lontano dall'industria culturale e dalla aggressione dci partiti». Tutto questo filone lo si trova sulle riviste «Ragionamenti» e «Officina», degli anni '55-'59. In fondo, il marxismo critico arricchisce l'analisi d'ispirazione marxista con l'apertura alle scienze dette borghesi, però non è veramente alternativo: infatti, dopo il 1956 (sappiamo che significa questo anno nella storia del marxismo) si invocò una profonda riflessione autocritica di tutto il marxismo, ortodosso o critico (di quest'ultimo Scalia sapeva indicare molto bene pregi e difetti), che operasse «quella radicale critica delle proprie premesse, sempre rinviata» per non es sere ancora una volta «profeti di un generico moralismo o di prospettive tanto remote da essere valide per ogni fine» (4). Tutto ciò porterà agli inizi degli anni sessanta ad un'apertura dei due marxismi verso le scienze e le ideologie del neocapitalismo, ma anche qui saremo di fronte ad un arricchimento di tematiche (e al pericolo di temi e metodi critici giustapposti), piuttosto che ad un approfondimento teorico - scientifico del pensiero marxista. Naturalmente, queste note non riguardano alcuni critici che nel dopoguerra si sono soltanto avvicinati al marxismo e che hanno <<'corretto» la critica crociana con il loro storicismo, in funzione del recupero (in arte e poesia) della storia e degli elementi allotri, respinti l'una e gli altri da Croce. Infatti, la linea Russo - Binni - Sapegno arricchisce la critica letteraria nella direzione di un superamento di Croce, particolarmente con una esigenza di interpretazione genetica dell'opera poetica da parte del Russo, con il metodo critico del Binni di Poetica, critica e storia letteraria ('63) immerso completamente in una elaborazione del concetto di poetica che, se segna un interessante avanzamento e superamento del Croce, con la introduzione di quanto viene prima dell'operazione formale, risulta essere anche troppo onnicomprensiva e carente del pur necessario punto di vista; infine, con gli studi del Sapegno, che possono interpretarsi come Russo + Binni + esigenza sociologica di derivazione gramsciana. La conversione di Sapegno al marxismo (1945) sembrò unire lo storicismo idealista e quello marxista in una versione «integrale», proprio perché la stessa critica marxista si fondava sulla Enea Vico- De Sanctis - Croce. In effetti, il suo marxismo sul piano teorico-scientifico è poca cosa , se pensiamo che il suo storicismo integrale era l'attenzione per <quella ordinata compagine di fattori culturali e di preferenze espressive (storicamente determinate è condizionate da una certa situazione sociale) che fornisce la trama su cui si elabora il processo della vivente fantasia » (5).
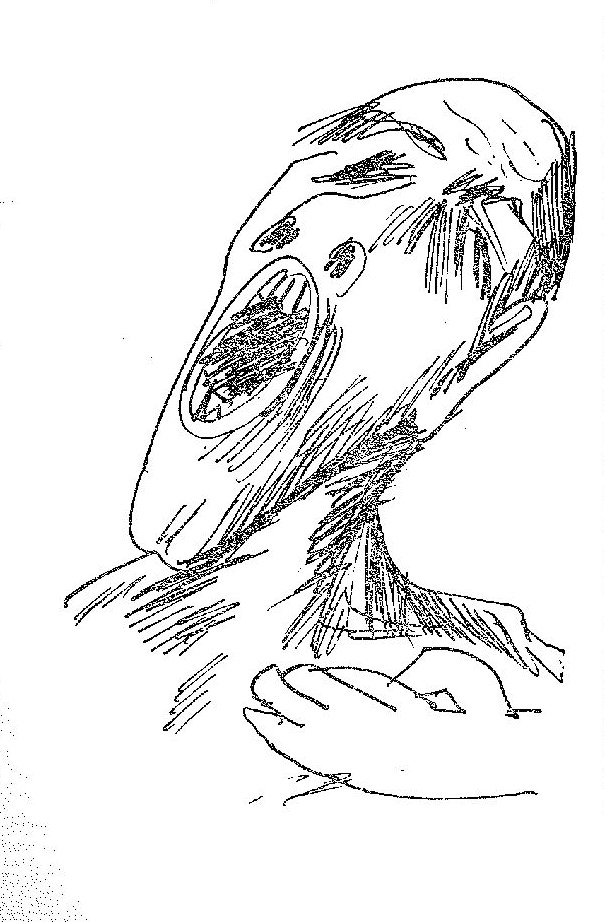
L'essenza del marxismo sapegnano era tutta qui. Fu possibile al Russo fare dell'ironia sulle parole del Sapegno, perché, in fondo, in quel senso anche chi non lo era si poteva considerare marxista ! Importissimo, invece, è sottolineare che l’inserimento dell'opera d'arte o poetica nella storia ha conseguentemente rinnovato la visione storiografica , per cui la storia della letteratura in autori come Salinari (6), Petronio (7), Manacorda (8), Asor Rosa (9), Muscetta (10), senza parlare di Marchese (11) o di Ceserani e De Federicis (12) (che presentano una nuova organizzazione del materiale culturale e letterario), non è più una somma di piccoli saggi e di ritratti degli scrittori, bensì un grande lavoro per spiegare unitariamente i fenomeni sociali e letterari. Siamo già alle soglie degli anni sessanta: si affermano ora nuove metodologie e tecniche di analisi di natura non marxista , ma anche nuove ricerche, validi “scavi” critici e nuove confusioni nell'ambito della nostra critica marxista. E tutto parte dalla grande e profonda svolta del 1956. Se questo è l'anno del XX Congresso del PCUS, dei fatti di Ungheria e dell'VIII Congresso del PCI, è anche vero che, da questo anno in poi, alle conseguenze di tali grandi eventi va unita, per l'Italia, la grande accumulazione capitalistica della ricostruzione iniziata nel dopoguerra, che produrrà attorno al '60 un gran de sviluppo economico. Quindi, avvengono alcuni fatti nuovi: la linea Croce - Gramsci ed il concetto di nazionalpopolare di quest'ultimo non reggono più dinanzi alla nuova realtà determinata da quello sviluppo, sicché la Sinistra è come spiazzata dal boom economico; l'abbandono di certi princìpi leninisti da parte del PCI, nell'insieme della situazione che si è determinata, significa allontanamento di molti intellettuali dalle posizioni dcl PCI e tentativi di una più approfondita conoscenza di Marx: Quaderni rossi ('61), Quaderni piacentini ('62), con grande influenza sui giovani. «Il loro tratto comune fu il tentativo di riattivare quella che ad essi sembrava la tradizione rivoluzionaria del movimento operaio nonché di ricoprire in sede teorica la radicale alterità del pensiero di Marx» (13). Quello sviluppo economico diveniva mitologia dello sviluppo e cambiò il costume, cominciava ad americanizzare la vita, veniva a significare ideologia americana, come dice Giuliano Procacci; quindi, tutto ciò spiazzò anche i cattolici, che da una parte sono nel potere DC, dall'altra sono in contraddizione con le loro basi morali evangeliche. Inoltre, si hanno altre due realtà importantissime: la scolarizzazione di massa (scuola media unica, 1962) e l'industrializzazione della cultura, con tutte le conseguenze che conosciamo.
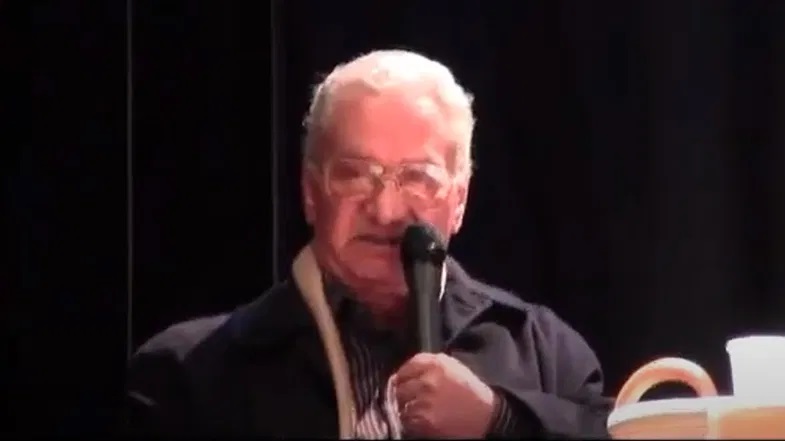
Scoppiano così realtà, situazioni e problemi nuovi di immensa portata. Il potere dominante ha bisogno di competenze, specializzazioni e, insistendo sulla crisi delle ideologie, impone la propria ideologia : l'impegno degli intellettuali tende ad annegare nella falsità dell'impegno scientifico di alcune discipline, sicché tutta l'attenzione si concentra nel metodo che nasconde l'ideologia, come è stato per un certo strutturalismo. Allora la situazione anche a sinistra si presenta molto complessa: tanti marxismi, ma tutti travolti dalla irruzione delle cosiddette scienze umane. Ora ci riferiamo al boom del formalismo e, soprattutto, alla egemonia ('60-'68) dello strutturalismo, al successo della nouvelle critique francese. Nella critica letteraria queste tendenze presentano un denominatore comune: la ricerca della letterarietà, di ciò che fa di un testo un'opera letteraria; quindi, l'analisi è tutta formale, perché nella forma si trova la soluzione del problema; e si studiano le strutture formali, e poi altre strutture, e poi accostamenti e relazioni di esse fino a formare il sistema strutturale. Questa letterarietà è connessa nei formalisti russi alla funzione poetica: se la funzione della lingua comunemente e praticamente usata è solo comunicativa , quella poetica non è così automatica, si qualifica. invece, attraverso uno scarto dall’altra . Allora si ha una forte concentrazione dell'interesse critico sui significanti e su come essi si presentano strutturati. Il fatto è che i significanti vengono intesi come significanti di se stessi (!), e se ne studiano pertanto tutti gli aspetti (fonetici, ritmici, ,ecc.) senza capire, per esempio, che l'interesse per gli aspetti musicali , pur legittimo, può far sottovalutare il lato semantico, fondamentale, della poesia: Galvano della Volpe avvertiva contro il pericolo di una «dissipazione sensuale del rigore razionale concreto della poesia». Ma, qual è la risposta teorica alle domande che la critica formalistica e strutturale pone al testo? La dà, in Italia , D'Arco Silvio Avalle, per il quale l'opera «Va intesa come il frutto di un'attività combinatoria». Ne deriva, dunque: a)che l 'approccio al testo è solo sincronico; b) che all'analisi non interessano le contraddizioni interne cd esterne al testo; c) che il lesto è totalità, valore assoluto e metastorico: i dati storici vengono semplicemente rimossi; d) che il critico dovrà far dipendere il suo giudizio di valore solo dalla più o meno integrazione degli elementi e delle parti costituenti il testo (ciò è in contraddizione con la dichiarazione di Jakobson, secondo. cui gli studi letterari non devono pervenire a un giudizio di valore: strutturalismo in contraddizione con se stesso !). Ebbene, è questa critica formalistica e strutturale che viene rifiutata e rigettata dalla critica n1arxista, 1a quale per la verità, è in grado di criticare e smascherare anche i maggiori esponenti non italiani dello strutturalismo. Nel '66 Massimo Cacciari e Francesco Dal Co dimostravano, alla luce dell'opera di Lévi-Strauss, che la struttura è per gli strutturalisti «un apriori trascendentale e, insieme, il carattere immanente del dato» (14). Da ciò deriva un esito tautologico, una vanificazione della dialettica della conoscenza, una astoricità, ed un esito solo sincronico; e ciò anche quando si esaminano più opere di un autore o di autori vissuti in tempi diversi, perché il rapporto tra critica e testi è sempre diretto e mai mediato dall'elemento tempo-spazio, e il testo è sempre considerato nel suo valore combinatorio. Per la verità, lo stesso Lévi-Strauss temeva questo errore quando diceva che «la critica letteraria strutturalistica ... troppo spesso finisce per ridursi a un gioco di specchi». Ciò dimostra che nello stesso strutturalismo vi sono critici che si rendono conto di certe sue aporie fondamentali e coreano di distinguere le due direttive della ricerca strutturalistica: per l'una la struttura appartiene all'oggetto, per l'altra la struttura si attua in un'operazione metodologica dei ricercatori di una singola materia, come dice Maria Corti. Bene, ciò trova spiegazione convincente nella dimostrazione di Cacciari e Dal Co. Eppure, c'è chi insiste (Barthes) nel dire che l'opera si presenta « priva di contingenza»! Sono note, d'altra parte, anche le mistificazioni ideologiche dello strutturalismo: il mito dcl tecnicismo socialistico e della neutralità scientifica, come pure la stretta relazione con la situazione socio-economica neocapitalistica. Tra gli altri, Petronio (15) ha smascherato lo strutturalismo, indicandolo come l'estrema manifestazione idealistica dello scientismo tipico dell'ideologia tecnocratica e capitalista. Questo astorico strutturalismo viene, dunque, smascherato e superato da una serrata critica marxista che vede i suoi risultati più alti in Sebastiano Timpanaro, Romano Luperini , Giuseppe Petronio, Galvano della Volpe, Ignazio Ambrogio. Timpanaro mette assai bene in evidenza, con grande rigore materialista, l'opposizione marxismo - linguistica strutturale, dovuta «alla nascita della linguistica strutturale europea dal movimento generale antimaterialistico e anti-marxista di fine Ottocento, e poi ai successivi influssi che ideologie spiritualistiche (a base matematicoplatonizzante o biologico - finalistica) hanno esercitato su singole correnti dello strutturalismo stesso.
(Fine Seconda parte)




