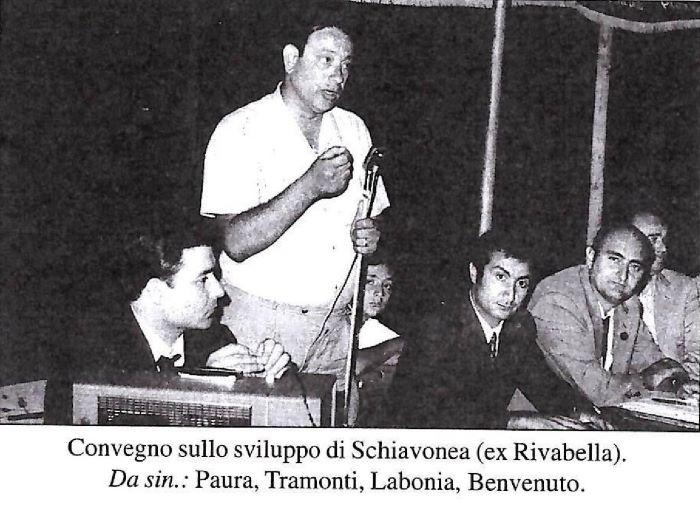
'A Cojja
La «Cojja» è una massaria posta fra il demanio marittimo, Torricella, Vrillia, Losina e Giannone. Ha una superficie di to molate 260 ed anticamente si chiamava «Zanetta».
Tale denominazione, secondo me, ha origine da "zana" per la posizione della massaria coincidente con la depressione massima dei terreni, che, qui avvallano. Infatti la «Skafarella», che l’attraversa, raccoglie acqua in sinistra ed in destra. Da Girolamo Sanseverino, prima ancora della congiura dei borboni, è donata in suffeudo ai nobilissimi Andronico, Teseo e Barnaba Abenante, ai quali la donazione viene ratificata nel 1488. Resta in possesso degli Abenante fino al 1811 allorché, per vendita, dal Rev. Francesco passa a D. Giacomantonio Cumano, da Vaccarizzo. Sulla massaria grava il peso enfiteutico in favore della Principal Corte prima e della Camera Ducale poi di ducati 5 e grana 49, nonché di tomoli 18 di grano e tomoli 3 e mezzo di orzo, misura rasa, annualmente. Cumano si rifiuta di pagare il censo al Duca, per cui ne nasce una lite che si trascina dal 1813 al 1834 attraverso la Giustizia di pace di Corigliano, il Tribunale Civile di Cosenza e la Gran Corte Civile di Catanzaro con esiti sfavorevoli al Cumano che si vede condannare al pagamento dei censi e perfino alla devoluzione della massaria. Subentrato D. Giuseppe Compagna negli interessi del Duca, mentre la causa è ancora in giudizio presso la Gran Corte, le parti addivengono a transazione per cui il Compagna acquista la massaria nel 1834. Gli Abenante la sottopongono ai primi lavori di trasformazione: ne incanalano le acque superflue nella Skafarella; la rendono seminativa per 140 tomolate; vi costruiscono una bella casa colonica con pozzo ed abbeveratoio. La restante superfìcie di tomolate 120 resta a bosco. Il tutto per come appare dalla descrizione del catasto del 1772. Fra gli Abenante ed i Sanseverino prima ed i Saluzzo poi spesso intervengono liti per via dei pascoli. Tanto perché ai suffeudatari spetterebbero le sole «mezzane» (una tomolata e mezza per ogni paio di bovi necessari ai lavori aziendali) ed al feudatario tutto il rimanente pascolo. Gli Abenante, invece, nei tempi e sovente, chiudono tutto il territorio utilizzando i pascoli per le proprie mandrie di bovini che marcano con una A sulle guance. L'indirizzo produttivo è cerealicolo zootecnico e sui seminativi si applica la rotazione biennale grano-pascolo, che diventerà grano-maggese. La espansione demografica del 1500 e, quindi, la maggiore domanda di cereali porta alla trasformazione della rotazione che diventa triennale del tipo grano-ringrano (in parte avena ed orzo) -maggese. Tale rotazione resiste fino a quando l'industria di trasformazione della radice di liquirizia, con i numerosi opifici sorti nella Piana, non rende mercantile il prodotto grezzo. La rotazione, per tale influenza rivoluzionaria, si trasforma in quadriennale del tipo, grano-ringrano-pascolo-maggese. Fuori rotazione e su superficie ridotta si coltivano ortive per l'auto consumo. Interessanti fra queste i meravigliosi meloni «Citrati>> ed i cocomeri «a barile” e tondi grossi neri. Tali varietà, frutto di secoli di selezioni, oggi, per l'uso indiscriminato ed assoluto di sementi americane, sono perdute definitivamente. Negli anni venti di questo secolo la coltura ortiva si espande e viene ad occupare il posto intercalare fra il maggese ed il grano della classica rotazione quadriennale. Oltre alle solite ortive, si coltiva il San Marzano da industria, il quale inizialmente viene scambiato con il conservificio Raspante di Palermo e successivamente con quelli di Pensabene e di Dragotta, frattanto sorti allo Scalo ferroviario. Le ortive si coltivano in aridocoltura per essere i terreni freschi da falde freatiche superficiali. Questa caratteristica, unitamente alla mitezza del clima, consente abbondanti produzioni da pascolo in tutte le stagioni, e quindi, rilevante carico di bestiame brado con stanziamento stabile non essendo necessaria la transumanza in Sila o sul Pollino. La conduzione è affidata al massaro con il sistema della «terra e semente» (mezzadria impropria), mentre l'organizzazione del lavoro è basata sui «gualani». Conduzione, organizzazione del lavoro e produzione meritano un discorso a parte, che, in questa sede non ci è consentito per ragioni di spazio. Con la promulgazione delle leggi sulla riforma fondiaria del 1950, i Compagna, temendo l'esproprio liquidano la «Cojja» in lotti da 10 a 50 tomolate. Essa oggi appare, per lo più, investita ad agrumi. I risultati della profonda trasformazione sono scadenti giacché la zona, per avere falde superficiali e per essere battuta da forti venti di grecale saturi di salsedine, non è adatta agli agrumi. Il fallimento di molte trasformazioni nella Piana di Corigliano è anche in funzione della carenza del ruolo guida dello Stato, il quale, anzi, spesso ha determinato quegli insuccessi elargendo sconsideratamente finanziamenti e contributi.




